Deforestazione: la best practice dell’Indonesia e le ambiguità europeeDI LUCA BELLARDINI
- 19 December 2022
- Posted by: Competere
- Categories: highlights, News, SUSTAINABLE NUTRITION
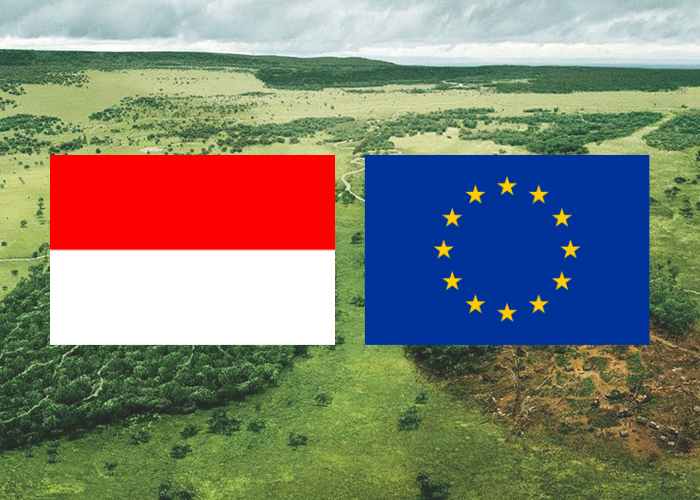
In materia di sostenibilità, la distanza fra il «dire» e il «fare» è ormai nota e ricorrente. Non mancano però gli esempi virtuosi: per esempio l’impegno contro la deforestazione, recentemente sancito dalla firma di un’importante dichiarazione d’intenti in materia — a margine della COP27 di Sharm-el-Sheikh — da parte di Indonesia, Congo e Brasile. Molti commentatori hanno sottolineato il valore di facciata dell’evento, cui certo dovranno seguire azioni concrete; eppure, per valutare la credibilità dei sottoscrittori, basterebbe leggere con attenzione i dati disponibili.
Prendiamo per esempio quelli relativi all’Indonesia. Lì, con una popolazione di 276 milioni di persone nel 2021 (+30 nel decennio precedente), gran parte della deforestazione è dovuta all’espansione delle aree urbane: un trend, peraltro, condiviso con varie zone dell’Asia sud-orientale. Eppure, non tutti pongono l’accento su un altro elemento, anch’esso di rilievo: il fatto che l’urbanizzazione, a sua volta, può essere la risposta agli effetti perversi del cambiamento climatico. La prova più evidente è offerta dalla costruzione della nuova capitale nella regione del Kalimantan, ora che Giacarta è minacciata dall’aumento del livello del mare.
Al di là di questo, i numeri dicono che — nonostante l’esigenza di fronteggiare un significativo aumento della popolazione e allo stesso tempo continuare a crescere — l’Indonesia resta tra i Paesi più avanzati nella lotta alla deforestazione. Non solo: a testimonianza della sua natura di economia emergente, è anche riuscita a rendere gli oli vegetali — come quello di palma — una componente assai rilevante del sistema produttivo nazionale, con una catena del valore che nasce in loco ma si estende su scala globale. Quanto viene sottratto al disboscamento selvaggio è dunque alla base di una filiera sostenibile e certificata, di elevata utilità in molteplici settori. I numeri di Global Forest Watch (link al sito) evidenziano che la deforestazione ha subito una decisa battuta d’arresto nel quinquennio 2017-21: sia per la minore estensione delle aree boschive sacrificate, sia per il ridotto impatto degli incendi. Se consideriamo il livello di «copertura vegetale» più elevato — dunque una definizione di foresta più restrittiva — tra quelli convenzionali (75%), notiamo che la quantità perduta di anno in anno è sensibilmente diminuita rispetto al picco raggiunto nel 2012, quando aveva superato quota 2,1 milioni di ettari (più dell’1% dell’estensione delle foreste nel 2000). Nel 2020, infatti, si è attestata sotto quota 800mila ettari: lungo quell’orizzonte temporale, in media, la deforestazione è arretrata dell’11,4% ogni anno. A quanto pare, invece, l’Europa sta sperimentando la tendenza opposta: un importante studio pubblicato su Nature (Ceccherini et al., 2020; link) riporta che, confrontando il triennio 2016-18 con il periodo 2011-15, i dati satellitari mostrerebbero una sensibile accelerazione dell’espansione delle aree coltivate a danno delle foreste (+49%) e anche della perdita di biomassa (+69%). Come sintetizzato in un paper di Mary S. Booth (link) per la Partnership for Policy Integrity, i dati dell’UNFCCC [Convenzione-quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici] mostrano non soltanto l’ampiezza del disboscamento ma, inevitabilmente, anche l’assottigliarsi delle riserve di carbonio nel terreno (che di per sé è forse ancora più pericoloso).
Per quanto possa sorprenderci la distanza tra le roboanti dichiarazioni ambientaliste dell’UE e la realtà delle cose, quanto sta avvenendo non è certo un caso. Innanzitutto si lega al rapido phase-out dei combustibili fossili, che è allo stesso tempo causa e conseguenza dell’impennata dei prezzi delle commodity energetiche: rispettivamente per la spinta regolatoria verso le fonti rinnovabili, dal lato dell’offerta, e l’«effetto sostituzione», determinato da prezzi relativi di consumi tra loro alternativi dal lato della domanda.
Il fenomeno spinge gli Stati membri dell’UE a riorientare le strategie in favore dei caloriferi naturali (es. la legna raccolta nelle foreste), in barba ai più elementari obiettivi di difesa del patrimonio ecologico: com’è noto, la biomassa che brucia è un cospicuo emittente di CO2. Nel 2020, peraltro, i volumi di utilizzo risultavano pari a circa 2,4 volte quelli del 1990: un’espansione trainata sì dal boom della produzione di energia, che pesa intorno al 30% del totale; ma anche dall’aumento comunque molto sostenuto del comparto industriale (poco più di un quinto del totale) e, in misura notevole ma inferiore, anche di quello residenziale e commerciale (quasi la metà dei volumi complessivi). Il risultato è che, col progressivo impoverimento dei terreni silvicoli, e a fronte di una domanda in forte crescita, la produzione di legname risulta ormai insufficiente a coprire il fabbisogno: alla fine, dunque, molti Paesi europei sono importatori netti di biomasse.
Alla luce di questo, va da sé che gli obiettivi net zero non solo al 2030 ma anche al 2050 risultano ormai irrealistici. Si ripropone in questo ambito, perciò, l’annosa dicotomia di Bruxelles: impegnata a ultra-regolare gli aspetti più minuti come le tecnologie domestiche, incapace di esprimere una visione coerente sulle grandi questioni strategiche di respiro internazionale. In ambito di policy, la strada da percorrere è ancora lunga: dall’armonizzazione normativa a una più efficace definizione degli obblighi di disclosure su questo tipo di attività, fino alla ridefinizione degli obiettivi per evitarli che vengano perseguiti tramite mezzi assai discutibili.
La deforestazione delle aree tropicali non è certo una «pagliuzza», ma non possiamo ignorare la «trave» nell’occhio dell’Europa: soprattutto guardando alle best practice di Paesi come l’Indonesia, che ha molte più aree vergini ed esigenze di sviluppo ben più pressanti delle nostre.
